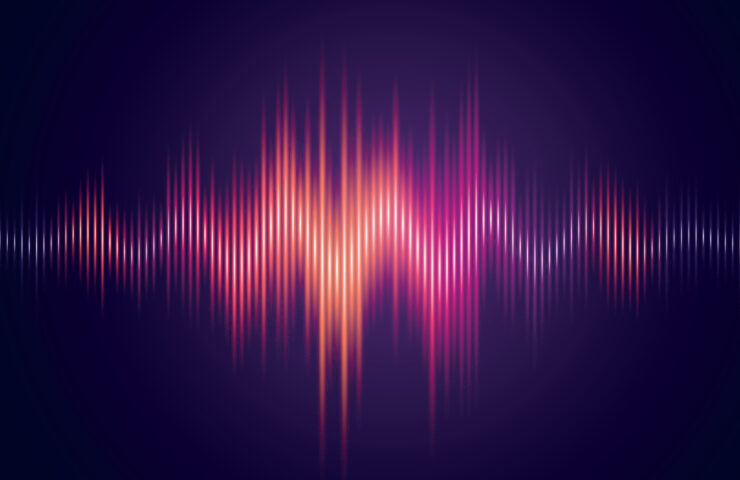Siamo ormai al cospetto della migliore versione di noi stessi: un essere umano digitale che comprende, ragiona, crea, interagisce empaticamente
“Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole”. Inizia così il primo versetto del capitolo 11 della Genesi. E racconta della Torre di Babele (un progetto di co-housing universale che altro che Ikea), alta fino al cielo e a cospetto della quale il Burj Khalifa è una villetta a due piani. Le cose andarono come andarono (scese il Signore a distruggere l’opera e disperdere gli uomini su tutta la terra, confondendo loro la lingua) ma al netto di ogni esegesi, la lezione non fu appresa.
Così come potremmo paragonare i Big Data alla Biblioteca di Alessandria – e infatti anche i server vanno a fuoco e anche ora quando accade è una mezza tragedia – possiamo vedere nella distesa di Server Farm l’ombra proiettata della Torre di Babele. Il sogno della conoscenza universale finalizzata a una comunione tra gli uomini e tra questi e la natura. La risultante attesa dovrebbe essere un’equa e ben distribuita felicità.
Nell’andirivieni della storia questo progetto si è misurato con tecniche (l’essicatura del fango e l’uso del bitume per realizzare e saldare i mattoni l’uno all’altro) e conoscenze varie il cui punto di arrivo, oggi, è il tap.
Con un tap – il click fatto con il dito sulla superficie in vetro di uno smartphone – entriamo nella stanza di un vietnamita appena sveglio e gli diamo il buongiorno, scarichiamo il referto medico, paghiamo il bollo auto e chissà cos’altro ancora. Eccolo, il punto: cos’altro ancora?
Perché per servire la popolazione mondiale per intero in ogni suo bisogno, aspettativa o capriccio bisognerebbe avere un’altra popolazione mondiale per intero allocata sulla Luna che notte e giorno si presti ad attendere e assecondare gli input di ogni singolo tap.
Il problema deve essere stato preso molto seriamente in considerazione negli anni addietro e la valutazione dei pro e contro (Space Economy, Laser Communication, Dolly umanoidi, Sindacati intergalattici) ha fatto abbracciare a tutti la stessa strada, quella della digitalizzazione e dell’automazione. Banhof, l’ex bunker atomico nei pressi di Stoccolma, è stato ritenuto più accessibile della Luna, come anche il fondo del mare al cospetto delle Isole Orkney, e sono questi alcuni dei luoghi che oggi ospitano le Server Farm che connettono il mondo in un tap. Tutto risolto? Nient’affatto.
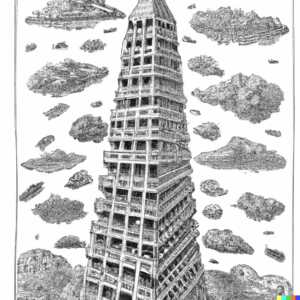
Perché collegare non significa connettere. E qui il problema si è fatto più raffinato. Come portare le persone a preferire un’interazione digitale a una umana? L’ottimismo della ragione aveva scavalcato il problema con un doppio carpiato: se l’interazione digitale sarà più veloce ed efficace, nessun uomo razionale preferirà recarsi di persona alle poste e perdere il doppio del tempo quando potrà fare la stessa cosa comodamente da casa sua.
Primo salto carpiato: “se sarà più veloce ed efficace”. Avete mai provato a dialogare con una piattaforma automatica per il rimborso dell’Ecobonus? Ecco, armonizzare la logica di un programmatore, quella di una PA, quella di un sistema informatico e le infinite logiche esistenti sulla terra per causa della disfatta di Babele, è una prima sfida a tutt’oggi mai vinta (se, per contraddire il punto, pensate alla “E-Stonia”, pensate anche che dal 2017 non si fanno altri esempi e che quello fu più il Proof of Concept di una Nazione di fondazione che una vera transizione digitale).
Secondo salto carpiato: “nessun uomo razionale preferirà perdere tempo, recandosi fisicamente in un luogo…”. Ci aveva già provato Rousseau a teorizzare sistemi sociali funzionanti sulla base di questo “Candido” presupposto. Ma l’umanità non è geometrica e non esistono assunti euclidei: c’è il vedovo che non ha nulla da fare; l’anarchico diffidente; il refrattario; l’abitudinario; l’amante del postino; lo scrittore zavattiniano; il no gender ribelle alla logica binaria dell’informatica e l’assenza del terzo flag nel form da compilare. C’è il disoccupato, quello che si è appena trasferito, quello che non ha i soldi per la connessione e l’aspirante attore in cerca di personaggi. C’è, insomma, tutta la varietà umana, una scala tonale che rivendica per sé un posto cromatico nel mondo in bianco e nero dell’efficienza cibernetica.
Quando le Big Tech si sono accorte di questa irriducibile varietà umana che è sabbia negli ingranaggi digitali ha preso l’epifania e, come fa sempre, l’ha tradotta in una moltitudine di task. Ammirabili, eccezionali. Ma… il risultato è stato l’antropizzazione delle relazioni automatiche, attraverso l’imitazione di quanto ci sia di più umano: l’ineffabile. La comprensione del linguaggio umano, con le sue imprecisioni, poi con le sue particolarità e inflessioni, infine con l’analisi del Tone of Voice, e ora anche con il linguaggio non verbale: l’espressione del viso.
Oggi siamo al cospetto della migliore versione di noi stessi: un essere umano digitale che comprende, ragiona, crea opere d’arte musicali, grafiche e qualcosina anche fa sulla narrativa – ma soprattutto che interagisce in modo empatico. Apprende e insegna. Semmai capitasse che non abbia la risposta giusta, non improvvisa né tergiversa e non azzarda, ma con la placida consapevolezza socratica ti dice che sa di non sapere. Non è più solo un campione di scacchi, si candida a essere un maestro di vita.
Dubitare che tutto ciò porti più vantaggi che svantaggi è come essere un professore di matematica contrario alla calcolatrice. Chiedersi però se sia sano, vantaggioso ed eticamente preferibile ridurre le differenze che marcano chiaramente la distanza tra un’intelligenza artificiale e un essere umano, mi sembra un atto dovuto.
L’ambiguità e, in un futuro molto vicino, l’impossibilità di distinguere chi hai davanti introduce notevoli problemi: il trust, l’altro, il tempo e lo spazio e, infine, lo scopo dell’io. Che tradotto significa: se so di non saper riconoscere nell’altro la natura, l’origine e lo scopo, non posso credere a ciò che mi dice. Se so di non potermi fidare, sono solo. Come essere umano solo sono definito non più dalle relazioni ma dal tempo e dallo spazio – limitatissimi – che mi appartengono.
Per un’eterogenesi dei fini il cannocchiale si rovescia e alla fine del viaggio espansivo compiuto attraverso la digitalizzazione di tutti i miei sensi non mi ritrovo con un corpo più esteso, una conoscenza più ampia, uno sguardo capace di vedere l’infinitamente lontano e il vicinissimo, ma l’esatto contrario: ho contezza e consapevolezza certa solo e soltanto di ciò che esiste nei confini della propriocezione. E solo su questo posso agire, con una drammatica riduzione dei miei scopi. Rischio, cioè, di disperdermi su tutta la terra e avere la mia lingua confusa con quelle di tutti gli altri. Babele docet.