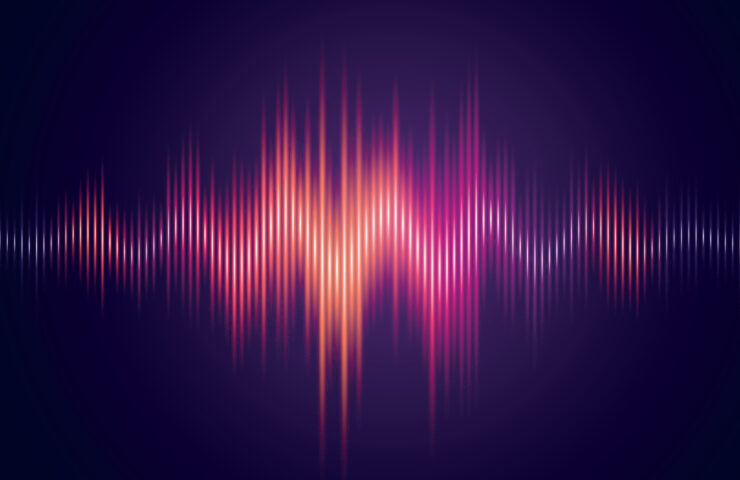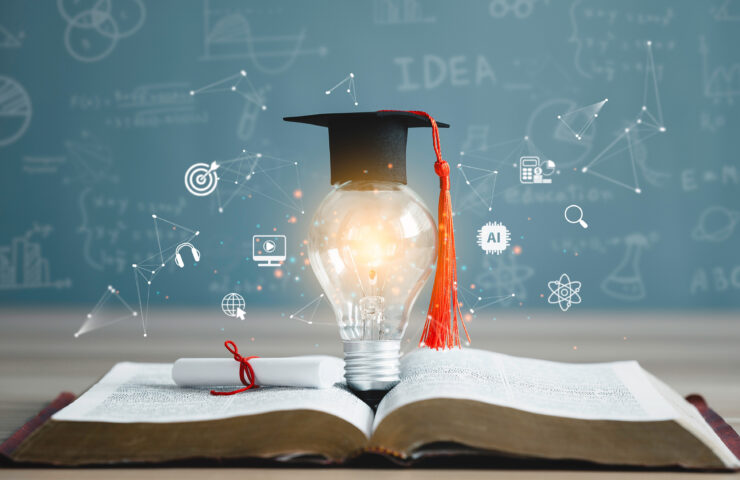Intelligenza artificiale e dibattito femminista: l’AI può illuminare le controversie di genere? Un viaggio nell’uso dell’AI per analizzare il dibattito su femminismo e identità in occasione dell’8 marzo
A pochi giorni dalla Festa della donna dell’8 marzo, mi sono imbattuta nella lettera aperta di ArciLesbica. L’ho letta una, due, tre volte, sentendo crescere dentro di me un miscuglio di emozioni contrastanti. Come spesso accade nei dibattiti su femminismo e identità di genere, le parole sembravano cariche di significati stratificati, interpretazioni divergenti, verità parziali presentate come assolute. “Deve esserci un modo più oggettivo per analizzare questo testo”, ho pensato. Ed è allora che ho avuto l’intuizione: perché non usare l’intelligenza artificiale come alleata in questa esplorazione?
Ma facciamo un passo indietro. Negli ultimi giorni, una lettera aperta firmata da ArciLesbica ha riacceso il dibattito su femminismo, identità di genere e inclusione. Il documento, pubblicato in vista dell’8 marzo 2025, critica l’uso del linguaggio neutro, la partecipazione delle persone trans agli spazi femminili, la regolamentazione della prostituzione e la gestazione per altri (GPA).
Un testo che ha generato reazioni forti, sia in chi lo sostiene sia in chi ne contesta le premesse. Mentre leggevo la lettera, mi sono chiesta: come possiamo affrontare una discussione così polarizzata senza cadere in semplificazioni o pregiudizi? Ho deciso, quindi, di sperimentare l’uso dell’intelligenza artificiale per analizzare il testo, cercando di individuare eventuali incongruenze e fallacie logiche e argomentative. Può l’innovazione tecnologica, e in particolare l’AI, aiutare a decifrare un dibattito così complesso e polarizzato? Attraverso tecniche di Natural Language Processing (NLP), ho potuto evidenziare le strutture argomentative e verificare personalmente la coerenza delle affermazioni.
Ho deciso, così, di “abbandonare” parzialmente il metodo tradizionale di analisi testuale e di affidarmi alla potenza dell’intelligenza artificiale. Con la curiosità di un’esploratrice che si avventura in territori difficili, ho caricato la lettera su ChatGPT senza troppi indugi.
L’analisi ha rivelato diversi elementi interessanti. Per esempio, alcune argomentazioni della lettera si basano su una visione essenzialista della donna, che ignora le evoluzioni scientifiche e filosofiche del concetto di genere. Inoltre, con le dovute verifiche a posteriori, non ho riscontrato allucinazioni da parte dell’AI né si è persa nella cosiddetta “falsa neutralità”, ovvero l’illusione che entrambe le posizioni in un dibattito abbiano lo stesso peso scientifico, quando in realtà esistono dati consolidati che supportano una prospettiva più ampia e inclusiva.
Premesso ciò, andiamo con ordine. La lettera potete leggerla qui. Di seguito, vi riporto le fallacie e le incongruenze analizzate con l’AI.
Leggi anche: I dati sono neutri? Parliamo di Data Feminism con Donata Columbro
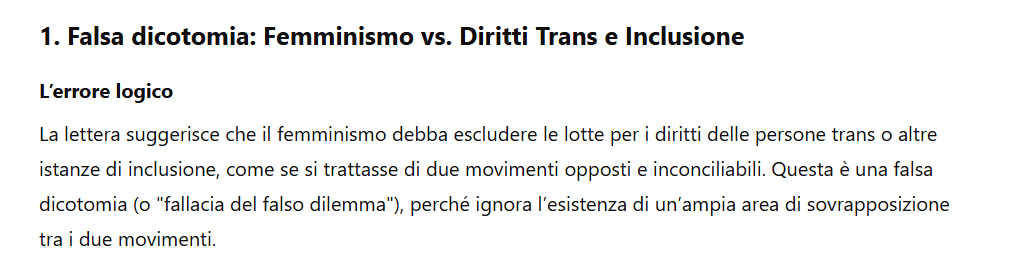
Il femminismo, contrariamente a quanto sostenuto dall’associazione nazionale ArciLesbica, non è mai stato un blocco monolitico. Dagli anni ’70, diversi filoni hanno convissuto e si sono contrapposti, dal Radical Feminism (che enfatizza il ruolo biologico e sociale delle donne come soggetti oppressi dal patriarcato), al femminismo intersezionale (Kimberlé Crenshaw, 1989), che propone di combattere non solo il patriarcato, ma anche le altre forme di oppressione che si intersecano con esso – affinché ogni identità possa trovare pieno rispetto e dignità – fino al femminismo transfemminista, il quale riconosce che il genere è una costruzione sociale e che il patriarcato opprime anche chi non si conforma ai ruoli di genere tradizionali.
Il femminismo radicale, cui sembra ispirarsi la lettera, rifiuta il concetto di genere come costruzione sociale e vede nelle persone trans (in particolare nelle donne trans) una minaccia all’identità femminile. Anzi, in questo caso si parla proprio di “TERF” (Trans Exclusionary Radical Feminists, ovvero “femministe radicali trans escludenti”). Questo punto di vista, comunque, è controverso e criticato da gran parte della comunità accademica; per fare un paio di esempi, la filosofa Judith Butler, figura di spicco del femminismo e degli studi di genere, o Brunella Casalini dell’Università di Firenze, ne “La centralità della questione ‘trans’ per il femminismo”, pubblicato sull’International Journal of Gender Studies.
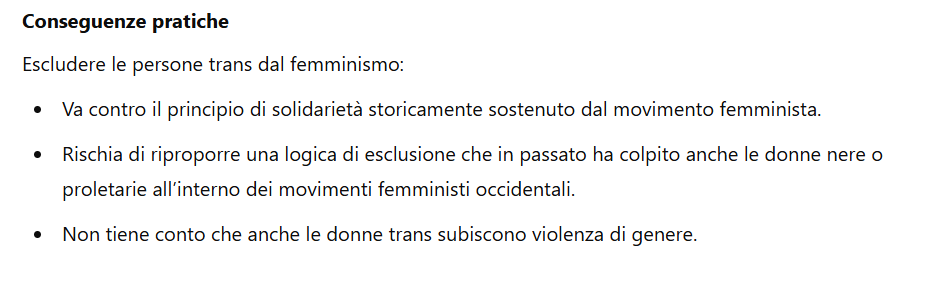
Nel testo è presente anche un equivoco terminologico. La lettera, infatti, usa il termine “trans-misoginia” come se fosse un tentativo di sovrascrivere il concetto di misoginia, quando in realtà si riferisce a una forma specifica di misoginia che colpisce le donne trans.
Vediamo ora il secondo errore logico analizzato da Chat GPT, che riguarda la definizione di donna. Nonostante sia scritto da un’AI, mi sembra molto più “umano” di quanto scritto nella lettera.
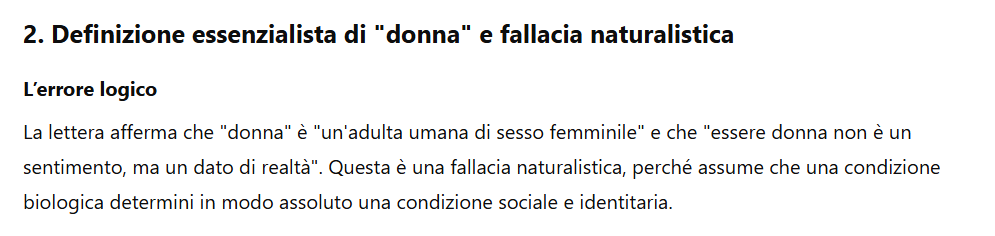
Nel corso della storia, la definizione di donna è stata tutt’altro che fissa. In molte culture indigene (i Two-Spirit delle tribù nordamericane, la comunità delle Kathoey thailandesi, il terzo genere in Madagascar chiamato Sekrata), l’identità di genere è fluida. Simone de Beauvoir, ne “Il secondo sesso” (1949), affermava “donna non si nasce, lo si diventa”, sottolineando il peso della costruzione culturale. Judith Butler, già nel 1990 in £Gender Trouble”, teorizzava il genere come una “performance”, ossia un insieme di atti sociali ripetuti che creano l’identità di genere. Affascinante, non trovate?
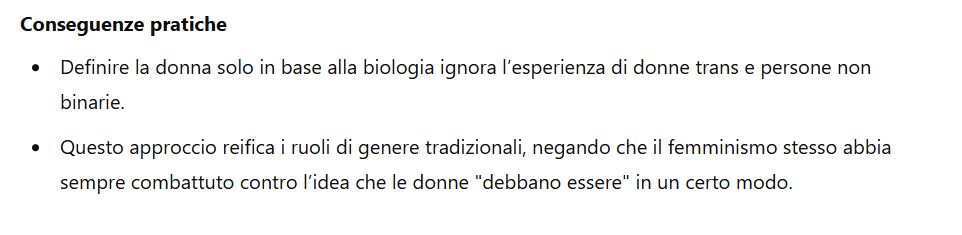
Se il concetto “donna” fosse un mero dato biologico, non si spiegherebbe perché in epoche diverse i ruoli femminili siano cambiati così tanto. Ma andiamo avanti. Nella lettera si legge: “il femminismo ci ha insegnato l’amore femminile per la madre, che la genealogia maschile ci spinge a negare. Il nuovo linguaggio neutro che cancella la nostra esistenza con simboli astrusi (asterischi, schwa, chiocciole) non tiene conto della forza delle relazioni tra donne di ogni età, fatte di riconoscimento reciproco e anche di gratitudine”. Vediamo cosa ci dice l’AI:
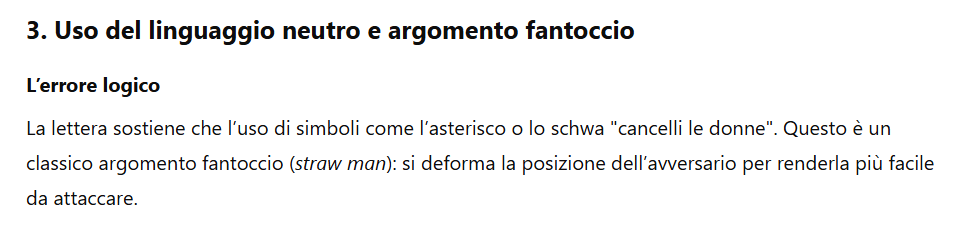
Nonostante l’argomento sia quasi banale, forse è il caso sottolinearlo ancora. L’evoluzione linguistica è normale. In passato “avvocata”, “sindaca”, “ingegnera” erano considerate versioni innaturali, ma oggi sono accettate. Il linguaggio neutro non “cancella” nessuno, ma amplia la rappresentazione di soggettività che prima non esistevano nel linguaggio. Sono la prima ad avere difficoltà a utilizzare sempre un linguaggio inclusivo, ma quando lo leggo online non mi sono mai sentita scartavetrata rispetto alla mia identità. La critica al linguaggio inclusivo presente in questa lettera ignora il fatto che il femminismo stesso ha sempre lottato per un uso della lingua che riconoscesse le donne. Un esempio è proprio il rifiuto del maschile sovraesteso.
Ascolta anche: La rete non ci salverà. Violenza digitale di genere e discriminazioni algoritmiche
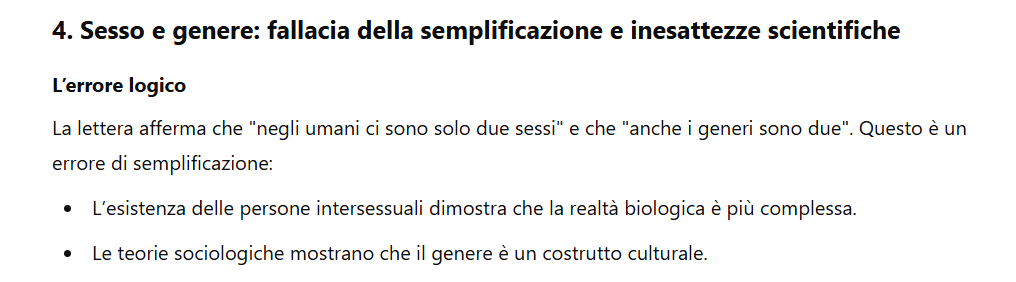
L’argomento secondo cui “negli umani ci sono solo due sessi”, come scritto nella lettera, trascura la realtà biologica dell’intersessualità e l’evoluzione delle scienze mediche e sociali, che riconoscono una complessità maggiore nella determinazione del sesso biologico e del genere. Nella lettera aperta, infatti, si legge “gli intersessuali sono eccezioni, non rappresentano tanti altri sessi, ma semplicemente un diverso sviluppo e una diversa combinazione dei caratteri femminili e maschili”. Eppure, la stessa OMS riconosce la distinzione tra sesso e genere; già negli anni Duemila, gli studi di Anne Fausto-Sterling (“Sexing the Body”, 2000) dimostrano che il sesso biologico non è binario, ma uno spettro. Nel testo divulgato da Arcilesbica c’è anche un vero e proprio appello alla paura, il cosiddetto Slippery Slope. Quando si parla della transizione delle persone adolescenti, si usa un linguaggio allarmistico (“vediamo con orrore”; “senza che si dica loro che cambiare sesso è impossibile”), facendo leva sulla paura invece di analizzare i dati medici e psicologici sui benefici e rischi delle terapie per la disforia di genere. Il testo, così, tende a suggerisce che l’autodeterminazione sul proprio corpo sia un’illusione imposta dal “capitalismo predatorio”, ma non spiega perché la libertà individuale debba essere vista come una forma di manipolazione anziché come un diritto personale.
Non da ultimo abbiamo anche un esempio della cosiddetta fallacia della falsa analogia, ossia situazioni molto diverse che vengono trattate come equivalenti:
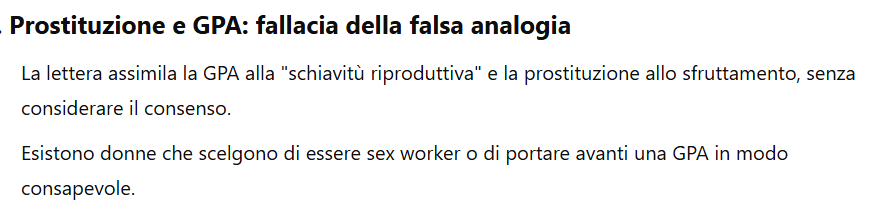
La lettera assimila la gestazione per altri alla “schiavitù riproduttiva”, senza distinguere tra situazioni di sfruttamento e pratiche etiche di GPA regolamentata e consensuale. Inoltre, il testo tratta la prostituzione solo come sfruttamento, senza considerare che esistono soggetti che la praticano volontariamente e che l’approccio abolizionista non è l’unico possibile per migliorare le condizioni di chi è coinvolto nel Sex Work.
Il testo, evidenze alla mano, presenta numerose fallacie logiche e argomentazioni non supportate da dati. Il femminismo non ha bisogno di escludere le persone trans o di opporsi in modo monolitico alla GPA o al Sex Work per essere coerente con la sua storia. Un approccio più aperto e intersezionale è necessario per affrontare la complessità del mondo contemporaneo.
Questo piccolo esperimento mi ha portato a una riflessione più ampia: come potrebbe l’AI trasformare il dibattito pubblico su temi controversi? Le piattaforme online e i social, infatti, sono spesso teatro di discussioni polarizzate che degenerano in insulti e disinformazione.
Leggi anche: Meta e diversità: la “rivoluzione conservatrice” che rafforza vecchi privilegi
Immaginiamo sistemi di AI avanzati in grado di identificare e segnalare contenuti potenzialmente tossici o manipolatori in tempo reale, evidenziare fallacie logiche e distorsioni cognitive nei testi argomentati. Non solo: potrebbero integrare strumenti di Fact Checking automatizzato, fornendo dati verificabili a supporto delle affermazioni in tempo reale. Questi strumenti potrebbero creare uno spazio di dialogo più costruttivo, dove le idee vengono valutate per il loro merito anziché per la veemenza con cui vengono espresse.
Tuttavia, come sappiamo, i modelli di linguaggio vengono addestrati su enormi corpus di testi umani, ereditando inevitabilmente i pregiudizi presenti in questi dati. Studi hanno dimostrato come molti sistemi di AI tendano a perpetuare stereotipi di diverso tipo. Inoltre, il fenomeno delle “allucinazioni” – quando l’AI genera informazioni plausibili, ma false – rappresenta un rischio concreto per l’affidabilità delle analisi.
Questa obiezione, pur comprensibile (io stessa ho parlato delle AI Hallucinations proprio qui), si basa su una visione dell’AI come oracolo infallibile, anziché come strumento analitico. I moderni sistemi di intelligenza artificiale hanno fatto progressi significativi nella riduzione delle allucinazioni, specialmente quando vengono utilizzati per analizzare testi esistenti e non per generare nuove informazioni; sono impiegati come strumenti di supporto all’analisi umana, non come sostituti e vengono integrati in sistemi di verifica che triangolano le informazioni con fonti multiple. Non in ultimo, i più recenti modelli sono configurati per esprimere incertezza quando appropriato, anziché fornire risposte definitive su temi controversi.
Ascolta anche: The Matilda Effect e perché ancora oggi non lo abbiamo superato
La vera forza dell’AI nell’analisi di dibattiti complessi non sta nella sua presunta infallibilità, ma nella sua capacità di processare rapidamente grandi quantità di testo, identificare pattern argomentativi e fornire una prospettiva complementare a quella umana.
La sfida rimane la stessa: usare questi strumenti con consapevolezza, senza rinunciare al pensiero critico e alla capacità di interpretazione umana.
La lettera di ArciLesbica, con tutte le sue controversie, ci offre l’opportunità di esplorare come i progressi tecnologici possano arricchire il dibattito pubblico su temi sensibili.
L’AI non è la soluzione magica ai conflitti ideologici, ma può essere uno strumento prezioso per elevare la qualità della conversazione. E spero che questo mio piccolo esperimento ne sia stata la prova. Ormai siamo abituati a dibattiti pubblici ridotti a slogan e reazioni emotive, l’approccio analitico offerto dall’AI secondo me rappresenta un’opportunità per ritrovare – e questo è paradossale! – profondità e complessità.
Un modo per onorare veramente lo spirito dell’8 marzo: non con risposte semplicistiche, ma con un impegno sincero a comprendere le molteplici dimensioni delle questioni femministe contemporanee.