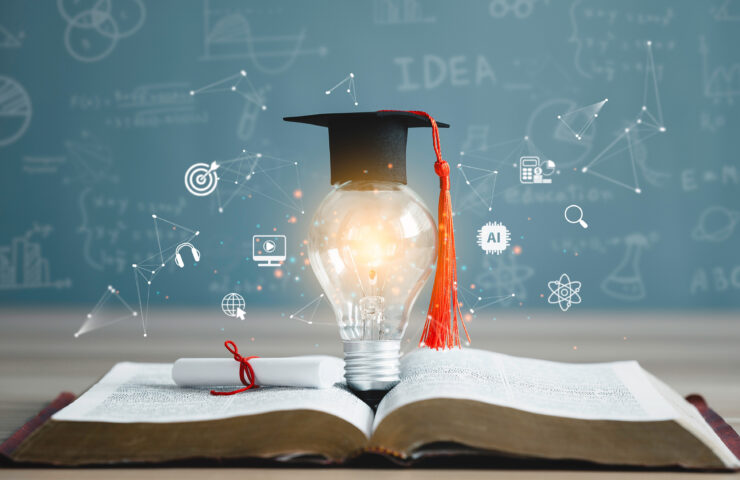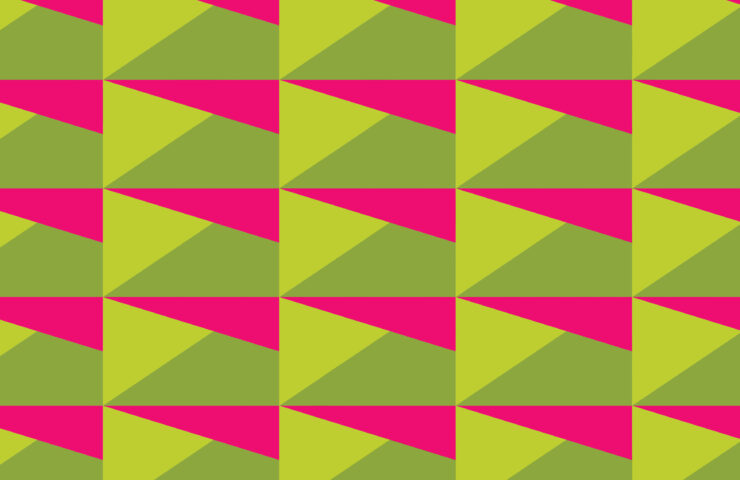Nel centenario della Facoltà di Scienze politiche alla Sapienza, i giuristi si interrogano sul rapporto tra regolazione e Innovazione
In questi giorni la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza di Roma ha celebrato i propri 100 anni di attività. “I mutamenti politici, sociali, istituzionali e normativi che si sono succeduti, a partire dal secondo dopoguerra fino alle soglie del terzo millennio, hanno imposto alla Facoltà un continuo riallineamento che, se da una parte ha comportato cambiamenti a volte repentini, dall’altra l’ha posta nella condizione di interpretare tali cambiamenti e di farsene interprete”, si legge nella locandina che annunciava la due-giorni di celebrazioni per il 17 e il 18 febbraio.

“È un centenario che cade in un momento non banale, nel mezzo di una rivoluzione digitale che convoca gli studenti a governarla. E progettare la società del futuro significa anche saper intercettare le nuove categorie dell’umanesimo digitale“, ha detto la Prof. di Diritto privato, Raffaella Messinetti, aprendo i lavori del convegno “Nuove tecnologie e nuove sfide per i diritti“. E ha aggiunto: “Essere all’altezza di questa nuova progettazione, è un compito non facile per i giuristi, ma è doveroso provarci”.
Sul rapporto tra regolazione e Innovazione tecnologica e i differenti approcci tra il modello europeo e quello statunitense, ha insistito nella sua dissertazione la Prof. Luisa Torchia, ordinaria di Diritto amministrativo all’Università Roma 3. Torchia ha spiegato come questa regolazione, in linea teorica, si basi su un equilibrio che oscilla fra due estremi: tra chi ritiene che la normazione sia un ostacolo all’Innovazione (modello statunitense) e chi, invece, ritiene che l’Innovazione comporti troppi rischi per non essere regolata (modello europeo).
E poi c’è l’esempio cinese – ha riferito ancora Torchia – “dove lo Stato controlla totalmente la tecnologia; si pensi alle disavventure capitate con Pechino al fondatore della piattaforma di e-commerce Alibaba, Jack Ma”. Ma anche – aggiungiamo noi – al sistema del credito sociale e al forte rischio che esso diventi uno strumento di controllo e censura nelle mani di un governo come quello cinese, già autoritario a sufficienza.
Leggi anche: La geopolitica di DeepSeek e l’annuncio che ha sconvolto i mercati
In ogni caso, oggi si assiste a una dinamica in cui sempre più Stati, non solo in Europa, ma anche in altri continenti, ritengono necessario normare l’Innovazione tecnologica, verso un sistema di regole che contengano i rischi già conosciuti e consentano di individuarne i nuovi. Va in questa direzione, per esempio, il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale entrato in vigore anche in Italia due settimane fa.
Tornando al convegno dell’Università La Sapienza, ha risposto all’appello della sua ex Facoltà, dove in passato ha conseguito anche un Dottorato di Ricerca, Claudia D’Andrea, oggi vice-segretaria generale della Camera dei Deputati.
Nella relazione che ha presentato, D’Andrea ha fatto numerosi riferimenti a “Machines of loving grace“, la recente opera di Dario Amodei, imprenditore e ricercatore statunitense, nonché fondatore e CEO di Anthropic, azienda che ha sviluppato la famiglia di LLM nota come Claude. Amodei è stato anche Vice President of Research di OpenAI. e, in “Machines of loving grace”, appunto, ci consegna un ritratto ottimistico del potenziale insito nell’AI di trasformare la società in meglio, rivoluzionando settori come la Salute e l’Economia, ma anche lo stesso governo della società. Anche se lo stesso Amodei ne riconosce i rischi.
Proprio sui rischi connessi a quella che ha definito “costellazione algoritmica“, ha insistito, invece, il Prof. di Storia delle dottrine politiche all’Università di Bologna, Maurizio Ricciardi, secondo cui gli algoritmi svolgono due specifiche funzioni politiche: la mediazione tra contenuti computazionali e culturali e una funzione di comando, che impone agli individui specifici comportamenti conformi alla loro esistenza digitale. In tal modo – secondo la definizione dello studioso – “le piattaforme non sono solo una nuova forma di impresa, ma anche un modello politico che investe lo Stato che, rinunciando a elementi della sua sovranità, riafferma il proprio ruolo specifico all’interno della forma politica algoritmica“.
Ascolta anche Meta e diversità: la rivoluzione che rafforza vecchi privilegi
Oreste Pollicino, invece, docente di Diritto costituzionale all’Università Bocconi di Milano, ha commentato i due regolamenti di cui si sta discutendo in Europa: il Digital Services Act e l’AI Act. Su quest’ultimo, in particolare, Pollicino ha avvertito del rischio che, a breve, ci saranno nuovi modelli in circolazione e, dunque, la normativa risulterà sostanzialmente obsoleta.
Per questo, il giurista ha consigliato di guardare, più che a una normativa secondaria come l’AI Act, alle Carte dei diritti fondamentali, quelle internazionali, e quella dell’Unione Europea, ma anche alle fonti primarie, cioè alle Costituzioni dei singoli Stati.
Tuttavia, nelle stesse ore in cui i giuristi discutevano a Roma di tecnologie e diritti, l’ex Presidente della BCE ed ex premier italiano, Mario Draghi, nel suo discorso al Parlamento europeo per la settimana parlamentare 2025, invitava, però, a fare presto, “perché la maggior parte dei progressi sta ancora avvenendo al di fuori dell’Europa, otto degli attuali primi 10 grandi modelli linguistici sono stati sviluppati negli Stati Uniti, mentre gli altri due provengono dalla Cina. Ogni giorno che ritardiamo, la frontiera della tecnologia si allontana da noi”, ha osservato Draghi. Resta da capire quale sarà il prezzo di questo ritardo.
Gaetano De Monte
Ascolta anche Gli impatti del Digital Service Act. Il caso Pornhub